Le visioni di Einstein e gli acidi del Dna
Pubblicato: 10 dicembre 2012 Archiviato in: Articoli | Tags: dai giornali, edizioni Dedalo, libri, Mattino, Michael Brooks, novità, Radicali liberi. Elogio della scienza anarchica, recensioni Lascia un commento
Il prototipo dello scienziato pazzo è un cliché ben presente nell’immaginario collettivo, un cliché che però emerge proprio in quanto eccezione rispetto alla regola. Il dottor Caligari, lo stesso Frankenstein (tendiamo a dimenticarlo, ma questo è il nome del creatore, non della creatura), il simpaticissimo Doc di Ritorno al futuro, sono miti rassicuranti, perché ci confermano che lo scienziato normale (lo scienziato vero) è di tutt’altra pasta: serio, preciso, corretto, chiuso in laboratorio con il suo immacolato camice bianco intento a ripetere diecimila volte lo stesso criptico esperimento, insomma anche un po’ noioso, “scientifico” diremmo.
Serio e preciso? Einstein non è solo quello della foto con la linguaccia, ma anche quello che manipolava serenamente i dati sperimentali per farli coincidere con le sue teorie (“E se non coincidono, diceva, mi dispiace per il Signore”). Corretto? Newton, lo scienziato per antonomasia, non spiegava agli altri le sue scoperte e, quando erano i suoi colleghi a farne, si batteva ferocemente per evitare che venisse loro riconosciuto qualche merito. Criptico e cauto? Ricercando il responsabile del morbo Bse, quello della mucca pazza, Prusiner coniò il termine “prione” senza neanche averlo individuato, senza neanche essere sicuro che esista davvero, ma ben sapendo che con un nome nuovo si sarebbe fatto pubblicità “attirando l’attenzione generale”. Noioso, scientifico? Crick, quello che insieme a Watson scoprì la doppia elica del Dna, era un utilizzatore di erba e droghe psichedeliche, e c’è la possibilità che l’intuizione che gli valse Nobel e fama l’abbia avuta sotto effetto di Lsd.

Michael Brooks, Radicali liberi. Elogio della scienza anarchica, edizioni Dedalo
Queste e molte altre curiosità, ben nascoste nelle pieghe della scienza ufficiale, sono state raccolte da Michael Brooks, scienziato e divulgatore, e si possono leggere nel suo Radicali liberi. Elogio della scienza anarchica (edizioni Dedalo, pag. 288, euro 15). La tesi di Brooks è che nella ricerca scientifica “vale tutto”, e che gli scienziati sono degli spiriti anticonformisti e insofferenti alle regole, disposti a qualsiasi cosa – anche a uccidere, anche a uccidersi – pur di fare una scoperta, e di vederla riconosciuta. Prendiamo le fonti di ispirazione, ad esempio. Einstein a sedici anni ebbe una vera e propria visione, in cui lui correva accanto a un raggio di luce e lo vedeva fermo: a quel punto poteva fare solo due cose, o creare superman o elaborare la teoria della relatività. Quasi un secolo fa, Otto Loewi scoprì che i segnali portati dai nervi sono di natura chimica e non elettrica: l’esperimento, che gli confermò la teoria grazie alla quale avrebbe vinto il Nobel, gli venne in sogno, come un terno al lotto. Mullis, un altro Nobel per la chimica, racconta che era sotto acido quando iniziò a vedere le catene di Dna fluttuargli davanti suggerendogli il modo in cui si potevano legare: evidentemente genetica e Lsd sono strettamente connessi. Faraday invece arrivò a fondamentali scoperte non ragionando sulla realtà ma sulla Bibbia: aderente a una setta cristiana fondamentalista, per lui la relazione tra movimento, elettricità e magnetismo era un riflesso della Trinità. E il mitico Copernico, arrivò a dire che era la terra a girare attorno al sole mica osservando, ma ispirandosi alle bizzarre teorie di un mistico greco dell’epoca di Socrate, Filolao di Crotone. D’altra parte, Enrico Fermi riuscì in un esperimento sul nucleare sostituendo all’ultimo istante un pezzo di piombo con un pezzo di paraffina perché… senza un perché, in quel momento così gli diceva la testa, sono fatti suoi.
Personaggi irrazionali, questi scienziati: e pure poco raccomandabili. Il cosiddetto metodo scientifico oggi è glorificato e ritenuto intoccabile come un dogma: eppure quelli che hanno usato scorciatoie e trucchetti sono molti, quasi tutti. E da sempre: gli storici della scienza attribuiscono la prima manipolazione di dati al patriarca Tolomeo, II secolo d.C.; mentre di Isaac Newton è il suo stesso biografo a dire che molti passaggi dei suoi libri sono “nient’altro che una frode deliberata”. Che poi molto spesso è la buona fede a spingere gli scienziati oltre il limite del lecito, la convinzione di aver ragione: aveva ragione Galileo a difendere l’eliocentrismo, che stentava ad affermarsi, ma tentò di dimostrare il sistema copernicano con le maree, una cantonata gigantesca. E lo stesso Einstein, la stupenda formula E=mc² non solo non fu lui a pensarla per primo, ma non riuscì neanche a dimostrarla, nonostante ci abbia provato ben otto volte durante la sua lunga vita: ma questo non vuol dire che non fosse nel giusto.
A volte l’ostinazione dei ricercatori è talmente forte, così pressante l’ansia di dimostrare una cosa, che in mancanza di alternative si mettono a fare esperimenti su se stessi: dobbiamo a questi raptus se oggi quando ci tiriamo un dente almeno è sotto anestesia (grazie, dott. Wells e il suo gas esilarante), se con un minuscolo sondino si riesce ad arrivare dall’arteria dell’inguine fino al cuore senza aprirci come un gamberone (e immaginate il giovane Forssmann fare tutto da solo e di nascosto, per poi correre in sala radiografie tutto allegro: guardate!), o ancora se sappiamo che la causa di molte ulcere non è solo lo stress, ma un batterio resistente all’acido dello stomaco, di cui il futuro Nobel Barry Marshall trangugiò un bel bicchierozzo a mo’ di cocktail.
Questa sarabanda di follie, tesa a mostrare che gli scienziati non sono poi così precisi, così corretti, così scientifici, che scopo ha? Quello di farci perdere fiducia nella scienza? Al contrario, sostiene Brooks: è proprio umanizzando gli scienziati, facendoli scendere dal piedistallo dell’infallibilità, dalla torre d’avorio della ricerca pura, che riusciremo a vederli nella giusta luce, e anche a dargli quel ruolo sociale che spetta loro. Come dimostra l’agghiacciante carrellata finale delle scoperte che la comunità scientifica ci ha messo anni, se non decenni a riconoscere, a volte mettendo a rischio l’intero pianeta: la pericolosità degli armamenti nucleari, il buco dell’ozono, la natura letale del Ddt. E oggi, l’effetto serra e il riscaldamento globale, ancora guardato con scetticismo da alcuni sedicenti scienziati: loro sì, veramente pazzi.
(Versione integrale dell’articolo uscito oggi sul Mattino di Napoli)
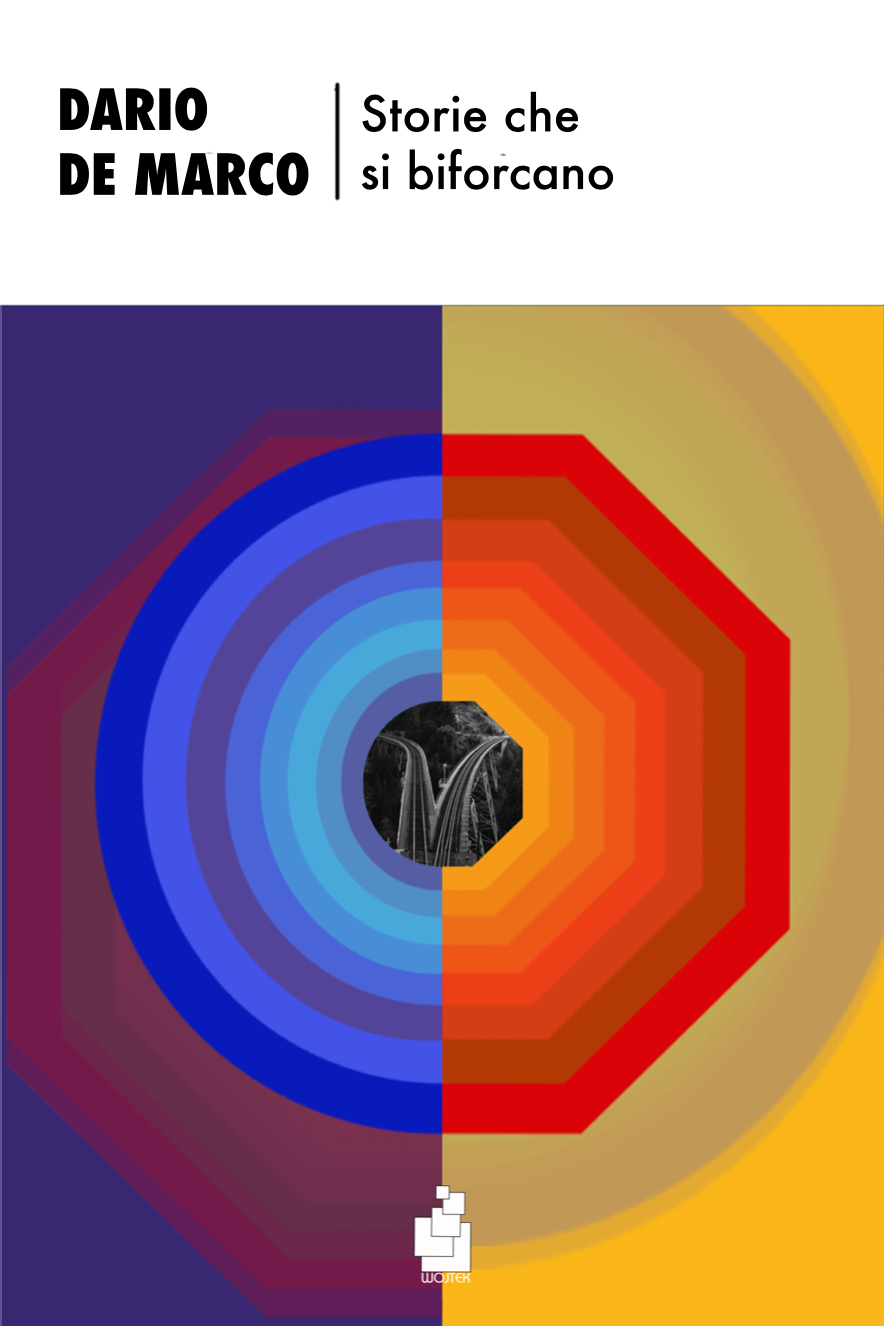
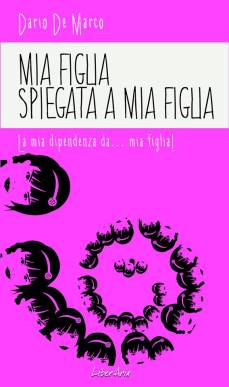

Ultimi commenti